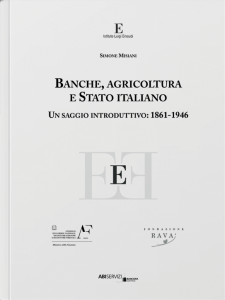
Simone Misiani, Banche agricoltura e Stato italiano. Un saggio introduttivo, Bancaria Editrice 2023
Con la prefazione di Maurizio Sella e la postfazione di Sabrina Diamanti e Gianluca Buemi
La ricerca, durata oltre tre anni, approfondisce l’apporto che il capitale impiegato nel settore agricolo, per il tramite dell’intermediazione creditizia, ha assicurato al processo di crescita economica dell’intero Paese, all’interno di una più ampia analisi storica del rapporto tra banche e territorio.
Sotto il profilo metodologico, infatti, l’autore si è riferito alle scienze sociali, tenendo peraltro ferma la separazione tra il compito della storia (interrogare il passato) e il compito dell’economia (costruire modelli quantitativi rivolti ad analisi previsionali). Ha quindi fatto propria la concezione di “storia totale”, tenendo insieme l’economia, la società e la politica in un approccio multidisciplinare di storia economica, ambientale, socioculturale ed istituzionale.
Fin dalle prime pagine appare chiara la tesi di fondo sostenuta nel volume: esiste un rapporto di reciprocità tra il sistema del credito e il mondo rurale, che grazie all’intervento pubblico non si disperde negli anni della grande trasformazione interbellica. In particolare, la scelta di orientare il risparmio sulla terra rappresenta il riconoscimento della necessità, da parte dello Stato, di farsi garante del mercato finanziario inteso come indispensabile strumento per la ripresa economica e per la riduzione della disoccupazione, da perseguire attraverso il finanziamento degli investimenti produttivi e l’allargamento del numero dei proprietari coltivatori.
La causa principale del cambiamento del rapporto tra banche e agricoltura maturato negli anni ’20 e ’30 è vista nel prevalere non di interessi economici, bensì di valori morali che hanno determinato l’indirizzo di governo verso una politica di credito speciale volta a dare una risposta adeguata al conflitto sociale del primo dopoguerra ed a favorire la ripresa dalla crisi agraria del 1928 e dalla Grande depressione. Di conseguenza, non c’è alcuna contrapposizione tra i fautori del sistema di intervento pubblico e i difensori del modello liberale, in quanto il credito speciale è la risposta alle conseguenze della crisi agraria e si afferma facendo leva sulla presenza di una forte cultura della cooperazione e della solidarietà sociale.
Il volume riserva ampio spazio all’apporto di elaborazione intellettuale sul nascente credito agrario assicurato negli anni ’20 da Luigi Einaudi, il quale avvia la sua elaborazione intellettuale sul nascente credito agrario nella fase di riconversione dell’economia di guerra.
In particolare Einaudi, osservando il progressivo aumento del peso della proprietà contadina determinato da un rilevante fenomeno di compravendita fondiaria favorito da condizioni contingenti quali il blocco degli affitti, il rialzo dei prezzi agricoli e la svalutazione della lira, valuta positivamente i provvedimenti di politica agraria contenuti nella legge di bonifica integrale ed apprezza i primi risultati della politica di credito agrario posta in essere dal regime per fronteggiare le crisi bancarie nelle campagne, approvando, tra l’altro, la conversione dei debiti degli agricoltori da breve a lungo termine.
Successivamente egli propone misure di azione pubblica basate su riduzioni fiscali e facilitazioni di accesso al capitale da impiegare nelle campagne e riconosce il valore e la necessità della spesa pubblica a fondo perduto per investimenti diretti alle bonifiche e alla colonizzazione agricola. Considerando prioritario l’obiettivo di incentivare l’investimento dei capitali sulla terra, Einaudi sostiene infine la funzione del credito cooperativo nel mondo rurale, in un quadro di complementarità con le altre banche aventi vocazione diversa.
